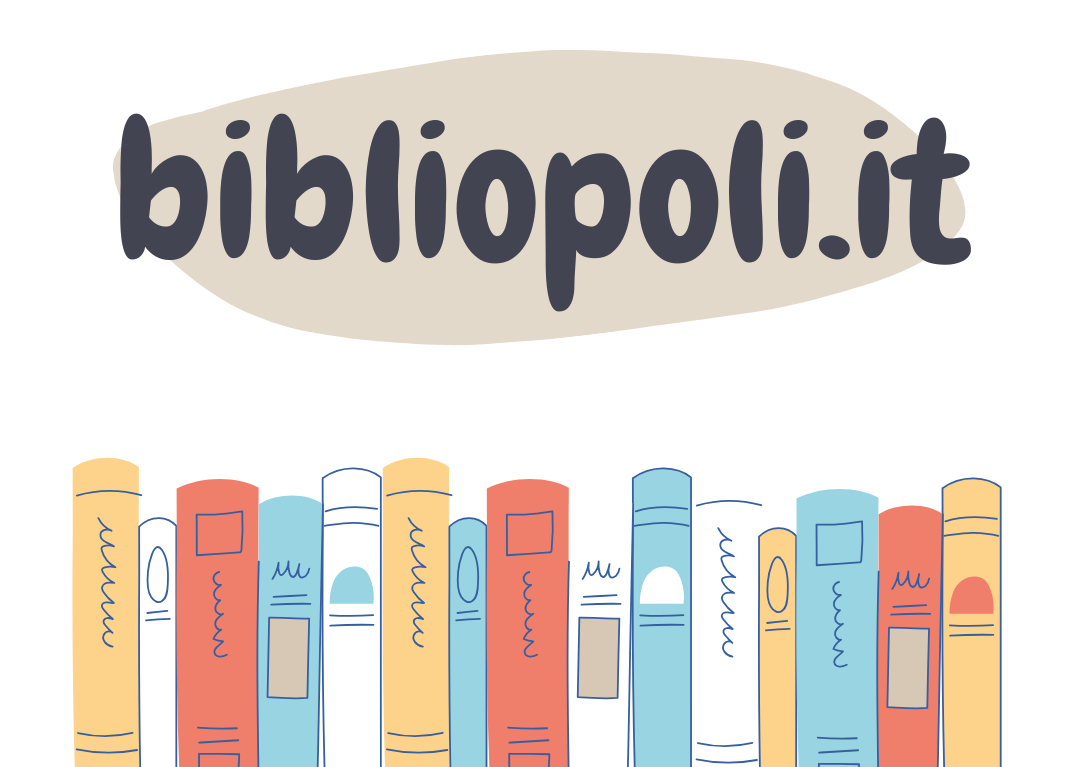Mercoledì 7 agosto sul Messaggero.it: «Flavio Briatore: “Crazy Pizza aprirà a Napoli a fine estate. Una Margherita? Costerà 17 euro, niente di esagerato”» (link) e la polemica ha proseguito il suo corso, registrando i pro, i contro e… gli astenuti. Ed il 17 settembre si registra l’apertura.
Una “nuova” pizza a Napoli, tuttavia, ha sempre i suoi perché, dice Briatore: «Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale». Indubbiamente Napoli-Pizza è binomio universale. Visto però che la cultura gastronomica è elemento fondante del nostro vivere, oltre il notissimo «primum vivere…», non è dato sapere se fra le letture di Briatore ci sia stata, o ci sia, Matilde Serao (1856-1927).
Un suo contemporaneo, Angelo De Gubernatis, che diresse un ponderoso Dizionario biografico degli scrittori contemporanei ornato di oltre 300 ritratti (Le Monnier, Firenze 1879), in quel volumone fece inserire anche una scheda in cui della Serao, nata in Grecia, ricorda che «suo padre Francesco, esule napoletano, avea sposato Paolina Bonely discendente dai principi greci Scanavy che diedero imperatori a Trebisonda» e che «sua madre, donna di gran coltura (conosceva il greco, il russo, l’inglese, il francese, l’italiano) fu alla giovinetta Serao prima istitutrice. Ella poi – si legge ancora -, che pur troppo la perdè, quando la madre l’era quasi divenuta sorella e compagna di studii, fece molto da sè, prese i suoi diplomi di maestra inferiore e superiore, e lesse senza fine».
Si ricorda quindi che i primi articoli «furono, nel 1879, raccolti in un grazioso volume intitolato “Dal Vero”, che ebbe le più liete accoglienze».
E proprio il mese scorso, ancora, un noto mensile di storia l’ha considerata «il brutto anatroccolo che conquistava i cuori e arrivò alle soglie del Nobel». «Femminista senza dichiararsi femminista», l’ha definita l’Ansa nel titolo di un dispaccio d’agenzia del gennaio 2023, ma a proposito delle letture possibili di Briatore, ci si è chiesto se mai si fosse dilettato a leggere Il ventre di Napoli, che questa «grande giornalista del romanzo» – le parole sono di Francesco Flora – pubblicò per la prima volta per i Fratelli Treves (Milano 1884) e poi ancora nel 1906 a Napoli, per F. Perella, con una notevole riscrittura, tanto che il frontespizio ne scandisce i tempi della revisione: «vent’anni fa, adesso, l’anima di Napoli».
«Nel libro, scritto in tre momenti diversi a partire dal 1884, Matilde Serao fa un’accorata descrizione dei quartieri più diseredati della Napoli del tempo. Protagonisti sono, quindi, il “popolo” napoletano e la sua vita quotidiana con le peculiarità che li contraddistinguono: tipo di alimentazione, forme di religiosità, lotto clandestino, usura, relazioni sociali… La situazione di totale abbandono in cui versano i suoi concittadini spinge l’autrice a muovere aspre critiche al sistema politico dell’epoca e all’amministrazione cittadina facendo risaltare per contrasto fulgide figure di “spiriti retti e puri che si ribellano all’infamia sociale”», riferisce un breve riassunto per il popolo navigante in internet.
Divise il libro in parti, l’autrice, e qui riprendiamo un lacerto del terzo capitolo (Quello che mangiano), che suono così: «Un giorno, un industriale napoletano ebbe un’idea. Sapendo che la pizza è una delle adorazioni cucinarie napoletane, sapendo che la colonia napoletana in Roma è larghissima, pensò di aprire una pizzeria in Roma. Il rame delle casseruole e dei ruoti vi luccicava, il forno vi ardeva sempre; tutte le pizze vi si trovavano: pizza al pomidoro, pizza con muzzarella e formaggio, pizza con alici e olio, pizza con olio, origano e aglio. Sulle prime la folla vi accorse, poi andò scemando. La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, pareva una stonatura e rappresentava una indigestione; il suo astro impallidì e tramontò, in Roma; pianta esotica, morì in questa solennità romana».
Quindi, un po’ oltre, Serao scrive: «È vero, infatti: la pizza rientra nella larga categoria dei commestibili che costano un soldo, e di cui è formata la colazione o il pranzo, di moltissima parte del popolo napoletano. Il pizzaiuolo che ha bottega, nella notte, fa un gran numero di queste schiacciate rotonde, di una pasta densa, che si brucia, ma non si cuoce, cariche di pomidoro quasi crudo, di aglio, di pepe, di origano – osserva -: queste pizze in tanti settori da un soldo, sono affidate a un garzone, che le va a vendere in qualche angolo di strada, sovra un banchetto ambulante e lì resta quasi tutto il giorno, con questi settori di pizza che si gelano al freddo, che si ingialliscono al sole, mangiati dalle mosche». E ancora: «Vi sono anche delle fette di due centesimi, pei bimbi che vanno a scuola – prosegue Serao -; quando la provvista è finita, il pizzaiuolo la rifornisce, sino a notte. Vi sono anche, per la notte, dei garzoni che portano sulla testa un grande scudo convesso di stagno, entro cui stanno queste fette di pizza e girano pei vicoli e dànno un grido speciale, dicendo che la pizza ce l’hanno col pomidoro e con l’aglio, con la muzzarella e con le alici salate». «Le povere donne sedute sullo scalino del basso, ne comprano e cenano – conclude Serao -, cioè pranzano, con questo soldo di pizza. Con un soldo, la scelta è abbastanza varia, pel pranzo del popolo napoletano».
Questa era ed è – ci si permette di dire – la pizza, oltre tutte le altre rispettabili tradizioni gastronomiche italiane. Un soldo di pizza per pranzare, scrive Serao; quasi 20 euro per la pizza gourmet della quale parla il noto imprenditore, con un’altra corrente di pensiero sulla pizza e sui costi, che si va attrezzando nei pressi della stazione Termini a Roma.
Spulciando cataloghi cartacei di librerie antiquarie e smanettando su internet si resta esterrefatti: sono in circolazione diverse lettere o cartoline interamente autografe della Serao. Ci sono comunicazioni ad editori ed a persone a lei care; colloqui epistolari con fotografi per ordinativi, semplici avvisi per appuntamenti. Il prezzo sul mercato varia da 150 a 180 a 350 euro e, quanto ai libri, fuori dai diritti di autore, della Serao, in edizione contemporanea, «Il ventre» si acquista davvero per pochi soldi ma chi volesse un’edizione dei fratelli Treves o quella del Perella, dovrà mettere mano al portafogli. Ecco, in questa temperie di metà settembre, le bancarelle dei soliti luoghi romani sono carenti del titolo, ma le librerie antiquarie no: è introvabile, intanto il «Ventre» dei Fratelli Treves, mentre per l’edizione pubblicata da Francesco Perella occorrono da 88 (Libreria Benacense) a 120 euro (Pontremoli).
Quel titolo “varrebbe”, dunque, quanto un ideale coupon da 5 o 7 (consideriamo una pizza gratis) Margherite al “Crazy” o quanto un abbonamento mensile per una margherita nelle pizzerie del centro storico napoletano, lì dove – come dicono i partenopei veraci – «ti sazi già al solo profumo». E nutrendosi di profumi (ma non troppo) restano anche i soldi per nutrire lo spirito con un bel libro di Matilde Serao.