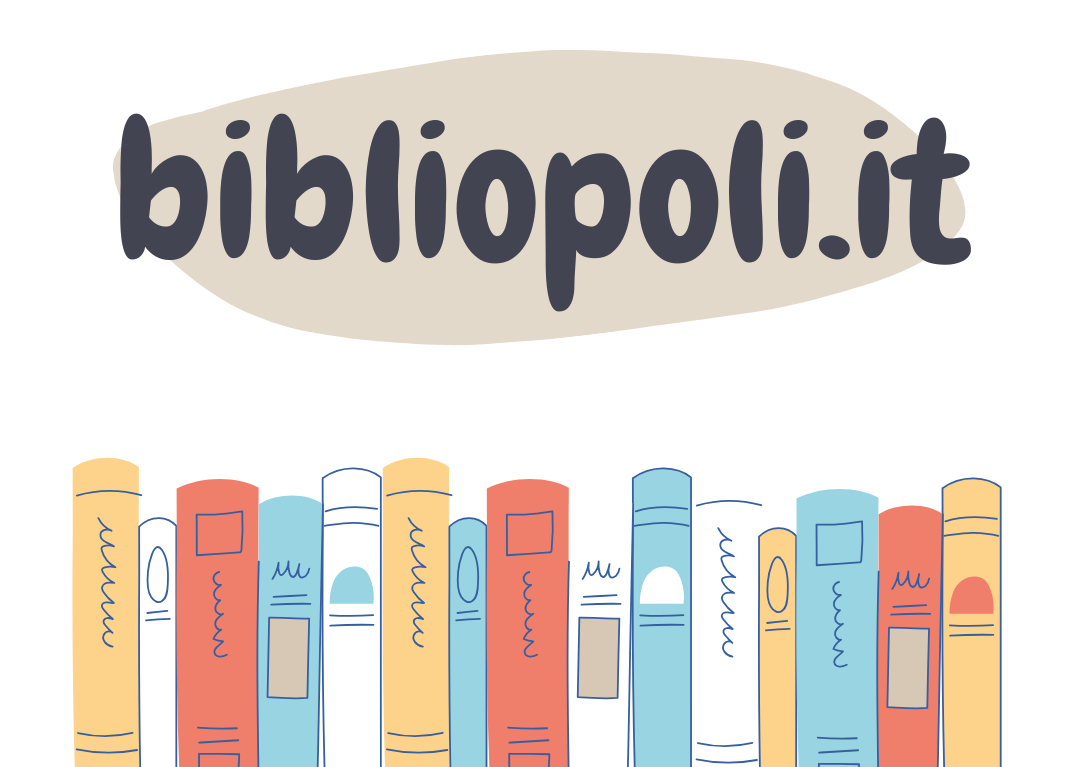Diavolo di un Titivillus! Il demone dei refusi, così tanto temuto nel Medioevo, colse l’attimo di distrazione di chi componeva il testo del colophon ed in quel torrido luglio romano di 500 anni addietro, andò ad inserire l’errore proprio lì, nelle note tipografiche dell’ultima pagina stampata, anteposte alle concessioni pontificie.
Così noi oggi, mezzo millennio dopo, prima di leggere: «con prohibitione, che nessuna possa stampare questa opera per anni diece, come appare nel Briεve concesso al prefato Lodovico dal santissimo nωstro Signore Papa Clemente VII per tutte le ωpere nuωve che ‘l stampa», abbiamo già notato che l’opera fu «stanpata (sic!) in Roma per Lodovico Vicentino Scrittore e Lautitio Perugino Intagliatore nel 1524 (MDXXIIII) del mese di Luglio».
È passata così alla storia la prima edizione a stampa della «Sωphωnisba» di Giovan Giorgio Trissino, che già nel 1518 l’aveva offerta a Leone X. «Letterato nato a Vicenza nel 1478 e morto a Roma nel 1550 – ci ricordano persino le enciclopedie tascabili -. Tentò di restaurare il classicismo in ogni genere letterario». E aggiungono poi che «nella questione della lingua sostenne la teoria della lingua italiana comune». Infine: «Scrisse la tragedia Sofonisba (1524), il dialogo Il Castellano (1529), il poema L’Italia liberata dai Goti (1547-48). La sua opera teorica più significativa è l’Arte poetica». Sette righe appena nella più nota delle enciclopedie tascabili; qualche riga in più nei manuali di storia della letteratura italiana in uso nelle scuole superiori, nei quali si ricorda come, in quella temperie, «si abbandonarono tutti gli schemi teatrali medievali e si mirò a un’opera di austera severità classica di compostezza “regolare”» e, proprio a proposito della Sofonisba, si osservò che fu composta «in endecasillabi sciolti».
La soddisfacente voce biografica curata da Valentina Gallo nel «Dizionario Biografico degli Italiani» dice che tale opera «nella storiografia gode del primato di prima tragedia regolare della letteratura italiana», dove per “regolare” si intende che vi era unità di luogo e di tempo e che l’azione si svolge sempre nello stesso posto e nello stesso giorno con in scena un numero limitato di persone.
Eppure, Giovan Giorgio Trissino è stato molto di più, fra incarichi politici e diplomatici, impegno di studio e di ricerca e, guardando alle non poche vicissitudini familiari, fra lutti e aspre liti parentali, potremmo dire personalità di estrema attualità, benché rampollo della nobiltà feudale. Ma poi, sarà vero che la mentalità del feudo non è ancora nel nostro Dna?
Quanto alla Sofonisba (si preferisce una grafia piana rispetto alla scelta operata dall’autore, in questo come in altri scritti di quell’anno, di inserire ω ed ε al posto delle o ed e lunghe nei caratteri latini), l’illustre storica del teatro del Cinquecento ci informa che essa era «ispirata» alle vicende della regina di Numidia, della quale aveva narrato Tito Livio. Ha guardato anche all’Affrica petrarchesca, la nostra studiosa, per cogliere affinità e risonanze ed ha concluso che nell’opera del Trissino vi è «una sua armonia, disegnando un modello di eroismo femminile problematico e tuttavia luminoso nella libido libertatis che porta la protagonista a eleggere la morte piuttosto che divenire prigioniera del nemico». Non solo. Con quest’opera «Trissino detterà legge sul versante metrico, forgiando per i drammaturghi dei secoli successivi la forma primaria del verso tragico: l’endecasillabo sciolto dalla rima».
Il 1524, del resto, fu un anno da considerarsi «speciale» per il nostro autore. Era fresco delle seconde nozze avvenute l’anno prima con Bianca Trissino, anch’essa vedova e ancora quella relazione coniugale non si era rivelata «complicata dalle rivalità e dalle gelosie della prole di primo letto di entrambi i coniugi» ed era asceso al soglio Clemente VII Medici, cugino di Leone X. Trissino probabilmente giunse a Roma proprio nel 1524, anno che, dal punto di vista dei titoli a stampa può considerarsi anno «trissiniano». A ben osservare, egli ebbe tutta per lui quella società attiva nell’Urbe e formata appunto da Ludovico degli Arrighi, incisore copista e tipografo che, proprio in quei frangenti fondò una società con l’incisore e tipografo Lautizio Perugino, che secondo il Dizionario dei tipografi era l’orafo e tipografo Lautizio di Bartolomeo dei Rotelli, che gestì la zecca di Perugia dal 1517 ed ebbe tre figli: Simone, Tito Teodoro e Caterina.
Fu quella società a stampare le opere del Nostro. Ludovico, in particolare, «produsse diverse opere a stampa un carattere corsivo appositamente creato, che riscosse l’apprezzamento generale conseguendo ampi consensi presso le tipografie della Francia.
Quella società tipografica, in quell’anno, stamperà la Canzone del Trissino al Santissimo Clemente p.m. ed ancora l’Epistola del Trissino de la vita, che dee tenere una dama vedova. Ecco soprattutto l’Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana, grazie alla quale ci si spiega la presenza delle ω ed ε al posto dei caratteri latini e quindi l’Orazione del Trissino al Serenissimo Principe di Venetia. Ricordiamo ancora I ritratti del Trissino, usciti in ottobre di quell’anno, ma soprattutto la Sofonisba, «stampata in Roma per Lodovico de gli Arrighi Vicentino Scrittore, nel MDXXIIII di Settembre» e conservata a Roma presso le biblioteche Vaticana e Angelica e a Londa presso la British Library.
Da luglio a settembre 1524: nel giro di qualche mese, dunque, si corse ai ripari ed è singolare che, eccezion fatta per la Biblioteca Vaticana, che conserva l’edizione con intervento “diabolico”, solo questa ristampa settembrina sia presente nelle più famose biblioteche della capitale. La prima edizione di luglio dove quel satanasso di Titivillus ci aveva insinuato il refuso è a Bologna (Biblioteca e Archivio storico di “Casa Lyda Borelli); tre esemplari sono nelle biblioteche di Firenze ed altrettanti nell’Universitaria di Pisa. Altri esemplare, ancora, sono custoditi nella “Augusta” di Perugia, nella Civica di Brescia, nella biblioteca del Convitto Nazionale Cicognani di Prato e nella Biblioteca Marciana di Venezia. Ma quell’edizione finita di stampare in luglio proprio non poteva restare a Roma: ne bastava nella Biblioteca Vaticana. Vade retro, Titiville!